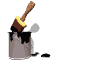|
La prosa "scientifica" e la poesia "meravigliosa" |
||||||
|
I numeri si riferiscono al libro di testo: Barberi Squarotti - Gigliozzi - Mercuri - Balbis - Genghini - Pardini, Letteratura , vol. 3A-B-C, Atlas, Bergamo 2004. |
||||||
|
percorso |
testi |
approfondimenti |
||||
|
1.
Galileo e la prosa scientifica Nel tardo Cinquecento e il Barocco si assiste ad un periodo di contrasti: religione vs società; filosofia della natura vs nuova scienza, ragion di stato vs diritto naturale. Il tutto all’insegna di quello che si potrebbe definire una “perdita del centro”. L’esigenza comune è quella di mettere in discussione i fondamenti del sapere aristotelico-tomistico. Ciò ha enormi conseguenze soprattutto in ambito scientifico, come si può vedere dai testi di F. Bacon e Cartesio. Tra le figure più importanti del periodo spicca senza dubbio quella di Galileo Galilei. In questa sede, più che lo scienziato, ci interessa lo scrittore, in particolare le sue scelte linguistiche (volgare vs latino, rinnovamento della lingua e sua risemantizzazione) e testuali (lettera, dialogo). |
|
F. Bacon, Natura e metodo (C 58) Cartesio, Il nuovo metodo Galileo, Il libro dell'universo (B,32) Lettera a Benedetto Castelli (B 28-31)
|
|
Il Seicento: coordinate storico-culturali (A 13-20)
Il cammino della scienza (C 44-46) Galileo Galilei (A 63-73) |
|
|
|
2.
La poesia barocca tra “brivido” e “meraviglia”
“È
del poeta il fin la meraviglia”: questo può essere il motto che
sintetizza la poetica barocca: superata l’idea classica di arte come
imitazione della natura, basata sull’equilibrio e la verosimiglianza,
si ricerca una novità espressiva capace di cogliere la
contraddittorietà del reale. Lo strumento privilegiato è la metafora,
figura teorizzata da Emanuele Tesauro.
Poeta
barocco per eccellenza è Giovanbattista Marino, prototipo di intellettuale
seicentesco, eccessivo nella vita come nella poesia. Al petrarchismo si sostituisce il marinismo, una poetica fatta di temi stravaganti, ma non priva di tematiche esistenziali, quali il senso della provvisorietà e l’illusorietà del reale, la morte, il gusto del macabro. |
E. Tesauro, La metafora (C 88-91)
|
L'età del Barocco (A 21-30)
Marino, il poeta della meraviglia (B 52-57)
|
||||
|
3. I corpi e le cose: sensualità barocca, estasi mistica
Una
caratteristica fondamentale della cultura barocca è il rilievo dato
alla sfera dell'esperienza e al mondo dei sensi. Il nuovo valore
riconosciuto alla realtà fisica è in parte dovuto all'indagine
scientifica, in parte è una conseguenza della capacità tipicamente
barocca, di mettere in discussione i modelli di spiegazione dei fenomeni
(sociali, economici, naturali e più in generale antropologici)
ereditati dai secoli precedenti. |
vedi qui per i testi e l'approfondimento | |||||