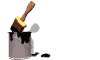L'organizzazione della cultura
| Pietro Abelardo, Historia calamitatum |
La
cultura medievale ebbe le sue sedi principali di elaborazione e
trasmissione nei monasteri, nelle scuole istituite presso le sedi
vescovili e, a partire dal secolo X, nelle università, e anche in scuole
indipendenti istituite privatamente da singoli maestri. In questi centri
si elaborò una precisa organizzazione didattica, che scandiva la giornata
dello studente, e un piano di studi articolato nelle sette
"arti". La vivacità di questi ambienti culturali è
testimoniata dalle lotte che nascevano tra i diversi maestri per affermare
la propria supremazia e accaparrarsi più studenti.
|
Una disputa teologica |
|
|
Pietro
Abelardo, uno dei maggiori filosofi e teologi del secolo XII,
è famoso soprattutto per
la storia del suo contrastato amore con l'allieva Eloisa, che gli
costò la castrazione, inflittagli per vendetta su mandato dei
parenti di lei. Il libro che raccoglie le lettere scambiate più
tardi tra i due, divenuti entrambi monaci, è introdotto da una
lettera autobiografica di Abelardo “a un amico”, intitolata Historia
calamitatum. In essa l’autore, oltre alla storia del suo
tormentato amore, narra la sua fortunata, ma contrastata carriera di
studioso. Il brano riportato si riferisce ad un periodo giovanile:
dopo aver frequentato la scuola di un famoso maestro di dialettica,
Abelardo ne ha aperta una per conto proprio; in seguito, per
approfondire la propria preparazione filosofica, frequenta la scuola
di un vecchio teologo, Anselmo di Laon, ma presto lo giudica una
nullità. Si inserisce qui l’episodio della disputa con altri
discepoli dello stesso maestro. |
|
|
Un giorno, dopo
esserci esercitati a confrontare le Sentenze,
noi studenti discutevamo
amichevolmente tra noi. Uno di loro, come per mettermi alla prova,
mi domandò che cosa pensassi dello studio delle Sacre Scritture, ed
io, che fino allora avevo studiato solo la filosofia, risposi che
quel tipo di studio era più utile di qualsiasi altro, perché
permetteva di apprendere ciò che è necessario per la salvezza
della nostra anima, ma che mi stupiva grandemente il fatto che delle
persone istruite come loro non si accontentassero, per capire i
commenti dei santi Padri, dei loro scritti o tutt'al più delle
glosse, ma avessero bisogno anche di un maestro, di una guida. Molti
dei presenti scoppiarono a ridere e mi domandarono se io mi ritenevo
in grado di commentare da solo i Sacri Testi. Risposi che se
volevano ero pronto a provare, ma essi si misero a gridare e a
ridere ancora più forte, dicendo: «Certo che siamo d'accordo!
Cercheremo e ti assegneremo un commento di qualche passo meno noto
della Scrittura, e vedremo se quel che prometti è vero.» E tutti
d'accordo scelsero un’oscurissima profezia di Ezechiele. Io presi il
commento e subito li invitai a venire il giorno dopo a sentire la
mia spiegazione. Essi allora, con l'aria di darmi un consiglio che
io non avevo certo richiesto, cominciarono a dirmi che su un
argomento così difficile non dovevo aver fretta e che, data la mia
inesperienza, avrei dovuto dedicarmi un po' più a lungo alla
preparazione e alla comprensione del commento. A questo punto mi
sentii offeso e risposi piuttosto irritato che non era mia abitudine
imparare le cose per mezzo dell'esercizio mnemonico, ma per mezzo
dell'intelligenza: e aggiunsi che avrei rinunciato definitivamente
alla prova, se essi non fossero intervenuti alla mia lezione all'ora
stabilita. In realtà alla
mia prima lezione erano presenti in pochi, perché a tutti sembrava
ridicolo che un principiante come me si sobbarcasse tanto presto a
un'impresa del genere. Ma la lezione piacque talmente a coloro che
vi erano intervenuti che non solo si congratularono con me ma mi
invitarono anche a continuare il mio commento secondo gli stessi
criteri. La notizia del mio successo si diffuse fulmineamente, e
anche coloro che non erano venuti alla prima lezione si
precipitarono alla seconda e alla terza e tutti erano
desiderosissimi di trascrivere le glosse che avevo dettato il primo
giorno, all'inizio delle lezioni. Naturalmente il
mio successo accrebbe l'invidia del vecchio Anselmo, il quale, già
infiammato contro di me dalle insinuazioni di quei suoi scolari,
cominciò a osteggiare me e le mie lezioni di teologia proprio come
Guglielmo aveva fatto quando insegnavo filosofia.
|
|
|
Abelardo è un intellettuale di tipo nuovo, combattivo, sicuro di sé: ama
la disputa, sfida le autorità riconosciute. In questo episodio è
da notare la contrapposizione tra intelligenza
ed esercizio mnemonico:
Abelardo avanza la pretesa di contestare ciò
che è trasmesso dalla tradizione attraverso l'uso autonomo e
personale della propria ragione, una pretesa inaudita e scandalosa
per i suoi contemporanei. Con questo spirito Abelardo svolse le sue
ricerche filosofiche e teologiche su basi razionali, senza una
preconcetta subordinazione della ragione alla fede cristiana (al cui
interno comunque intendeva restare). La novità del suo pensiero gli
costò la condanna per eresia di diversi concili, fino a una
scomunica. Il
tema dell'«invidia» dei vecchi maestri, che percorre tutta
l'autobiografia di Abelardo, getta una luce sul mondo dei nuovi
intellettuali dei secoli XI-XII:
le
scuole private e le cattedre nelle scuole vescovili sono una fonte
di lucro, la competizione tra i maestri è serrata, per conquistare
allievi e fama. |