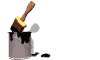A un amico fiorentino
| Dante, Epistula XII |
Nel
1310 Firenze offrì ai fuoriusciti per motivi politici un'amnistia, che
consentiva il ritorno in patria in cambio del pagamento di una multa,
del riconoscimento della colpa commessa e dell'accettazione pubblica del
perdono da parte della comunità cittadina. Con questa lettera, rivolta a
un amico fiorentino di cui non conosciamo l’identità (forse un
religioso, come si potrebbe dedurre dall'appellativo «padre»), Dante
rifiuta sdegnosamente di sottostare a queste umilianti condizioni.
|
Dalla
vostra lettera, che ho accolta con la dovuta riverenza e la dovuta
affezione, mi sono reso ben conto, con gratitudine profonda, della
cura e dell'impegno col quale cercate di procurare il mio ritorno in
patria; e per questo mi avete reso tanto più obbligato verso di
voi, quanto più raramente accade agli esuli di trovare degli amici.
Quanto alla mia risposta a ciò che mi scrivete, anche se non sarà
quale forse desidererebbe la pusillanimità di certuni, vi prego
affettuosamente che prima di giudicarla la ponderiate attentamente. Ecco
dunque quello che dalla lettera vostra e da quelle di mio nipote e di molti altri amici mi è stato reso
noto riguardo al decreto or ora promulgato a Firenze
sull'assoluzione dei banditi: che se io volessi pagare una certa
somma di danaro e volessi sottopormi all'onta della pubblica
oblazione, potrei essere assolto e ritornare immediatamente. E in
questo, invero, o padre, vi sono due proposte degne di riso e mal
consigliate; mal consigliate, dico, da coloro che le hanno avanzate,
infatti la vostra lettera, formulata con maggior senno e maggior
discrezione, non conteneva nulla di simile. È
questa, dunque, la graziosa revoca con la quale viene richiamato in
patria Dante Alighieri, dopo aver sofferto un esilio di quasi tre
lustri? Questo ha meritato la sua innocenza, manifesta a chiunque?
Questo i sudori e le fatiche continue da lui spese nello studio? Sia
lontana da un uomo che si professa intimo amico della filosofia una
così dissennata viltà di cuore ch'egli soffra di essere presentato
all'oblazione come un reo in catene al modo d'un Ciolo qualunque e
d'altri uomini infamati dalla loro colpa! Lungi da un uomo che si
professa banditore di giustizia che, avendo subito ingiustizia, a
quelli che gliel'hanno inferta, come a gente che abbia ben meritato
paghi il suo danaro! Non
è questa per me, padre mio, la via di ritornare
in patria; ma se un'altra prima da voi, poi da altri sarà
trovata, che non deroghi alla fama e all'onore di Dante, per
quella mi metterò a passi non lenti; ma se non c'è una via tale
per entrare in Firenze, io a Firenze non entrerò mai più. E che?
Non potrò forse da ogni luogo guardare le spere luminose del sole e
delle stelle? Non potrò forse, dovunque, sotto il cielo,
contemplare dolcissime verità, senza rendermi, prima, privo di
gloria, anzi, abietto al popolo e alla città di Firenze? Certo il
pane non mi mancherà. |
|
|
Sono
trascorsi più di dieci anni dalla condanna, e Dante vive a Verona,
ospite di Cangrande della Scala, che lo protegge e l'onora per il
suo prestigio di intellettuale. La presa di distanza dalle passioni
e dai conflitti della vita comunale gli consente di considerare con
uno sguardo nuovo la sua condizione di esule: un uomo che paga di
persona per la sua ricerca di coerenza e di rettitudine, un «intimo
amico della filosofia», un «banditore della giustizia» che può
dedicarsi alla contemplazione delle «dolcissime verità» in
qualsiasi luogo della terra. Il
desiderio di tornare a Firenze è ancora vivo, ma non può
comportare una rinuncia all'amore del vero e del giusto in cui Dante
identifica il senso della sua vita e del suo impegno di
intellettuale. |