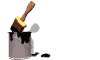De l'empia Babilonia ond'è fuggita
| Petrarca, Canzoniere, CXIV |
Nella
sua casa di Valchiusa, presso le sorgenti della Sorgue, a una trentina di
chilometri da Avignone, Petrarca si ritirava per sottrarsi agli impegni
mondani della corte pontificia e dedicarsi ai suoi studi. E' questo
il motivo autobiografico elaborato in questo sonetto, dedicatop ad un
amico, che si può datare al 1343.
|
De l'empia Babilonia, ond'è fuggita |
|
|
Il
sonetto ha (come pochi altri nel Canzoniere)
un carattere autobiografico d'occasione, e accenna una varietà di
motivi: la violenta condanna della curia papale (che è poi oggetto
dei tre sonetti "babilonesi"), il proprio amore, l'invito
e augurio a un amico. Ma il motivo che campeggia per metà del
componimento e gli dà il
tono è l'autoritratto ideale del poeta raccolto in solitudine,
serenamente dedito alla poesia, distaccato dalle ambizioni e
dal "volgo". È un ideale ispirato ad autori antichi cari
a Petrarca, da Cicerone, con la sua aspirazione all'otium degli studi, a Seneca, col suo ideale stoico del sapiente
superiore a tutte le passioni. Questo ideale, che Petrarca inseguì
per tutta la vita, non comporta per lui (come non comportava per gli
antichi) un rifiuto totale degli impegni e delle passioni, ma solo
un equilibrio interiore e un'alternanza di momenti; a questo sembra
alludere la struttura tematica del sonetto, dove l'immagine del
raccoglimento occupa le strofe centrali ed è incorniciata, nella
prima, dalla polemica politico-religiosa, nell'ultima, dal
riferimento agli affetti privati. La materia occasionale non esclude la consueta cura
formale. Si può osservare l'uso sapiente delle anafore e di altri
parallelismi che danno all'espressione una fluidità equilibrata e
armoniosa, come per rispecchiare l'equilibrio interiore dichiarato. |