JEAN AMERY
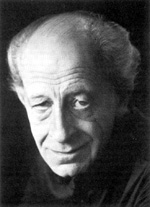
Quella
di Jean Améry è la riflessione, lucida, a freddo, di chi dopo vent'anni
(il libro è stato pubblicato nel 1966) ancora non è riuscito né a
dimenticare, né tanto meno a farsi capire. Ebreo austriaco, dopo la
guerra si stabilì in Belgio e ruppe con le proprie radici rinunciando
persino al nome di nascita, Hans Mayer, ma conservando l'esperienza del
lager come fondamento della propria esistenza, come il dramma a cui non si
riesce a dare risposta, come l'interrogativo che il tempo non cancella ma
amplifica.
Farsi
capire, farsi credere, far sì che chi ascolta non abbia né dubbi né
incertezze, è di qui, dunque, che la sua riflessione si muove. L'autore
sceglie esplicitamente come punto di vista quello
dell'"intellettuale", cioè dell'uomo dotato di sensibilità e
cultura (la sensibilità che viene dalla cultura) ma che non può
giovarsi, nel momento della catastrofe, né dell'ausilio della fede, né
delle certezze che vengono dall'ideologia.
L'intellettuale,
piuttosto, vive nel Lager l'esperienza del venir meno di ogni forma di
spiritualità. Egli vive l'onnipresenza della morte e il dramma di vedersi
sottratto ogni spazio di libertà che renda la vita degna di essere
vissuta. Ciò che è presente è piuttosto il "morire"
quotidiano e inesorabile. Questa esperienza però non è tale da
costituirsi in un sapere positivo, non è tale da far diventare l'uomo più
"profondo", anzi al contrario ha le caratteristiche negative di
una spoliazione: "Dal Lager uscimmo denudati, derubati, svuotati,
disorientati e ci volle molto tempo prima che riprendessimo il linguaggio
quotidiano della libertà."
Una
esperienza che non costituisce sapere, che non fonda una conoscenza. Una
esperienza dell'umano che implica la rinuncia ad ogni trascendenza, ad
ogni espressione spirituale, ad ogni astrattezza, ad ogni volo poetico e
scopre invece lo scoglio duro e impenetrabile della carne, della
sofferenza, del morire, della fame, dei corpi che si disfanno. Amery,
polemicamente nei confronti dei filosofi, afferma che le loro parole nel
Lager si rivelano inutili, e l'unico senso per l'Essere, cioè per le
grandi questioni della metafisica, è quello dell'essere affamati, essere
stanchi, essere ammalati.
Il
saggio si conclude molto amaramente, esprimendo uno stato d'animo simile
in modo singolare ed impressionante a quello con cui Primo Levi condusse
la sua ultima opera, I sommersi e i salvati: la contraddizione
insanabile tra il risentimento incancellabile della vittima che vede i
propri aguzzini rialzare la testa come se niente fosse, e il fastidio che
l'opinione pubblica sembra provare di fronte ai discorsi delle vittime.
Impressionante, anche alla luce della tragica fine di Amery, che si è
suicidato nel 1978, è la conclusione del libro, in cui l'autore sente
venir meno le sue forze e teme di non riuscire a trasformare la sua rabbia
di vittima in un impulso positivo alla testimonianza.
Il
brano che presentiamo mette a fuoco l'esperienza della impossibilità per
la vittima di abbandonarsi liberamente alle proprie fantasie. Anche
l'intellettuale che potrebbe trovare dentro di sé motivi di consolazione,
di conforto, è trascinato dalla realtà del Lager alla pesantezza della
materia. Lo stimolo per la riflessione, per l'esercizio dello spirito, gli
deriva soltanto dalla soddisfazione del bisogno primario del cibo. Perché
il Lager cancella l'umanità dell'uomo, riducendo ogni essere umano ad una
macchina biologica, senza interiorità.
Lo
spirito e il corpo
Il
cosiddetto Muselmann, come nel linguaggio del Lager veniva chiamato
il prigioniero che aveva abbandonato ogni speranza ed era stato
abbandonato dai compagni, non possedeva più un ambito di consapevolezza
in cui bene e male, nobiltà e bassezza, spiritualità e non spiritualità
potessero confrontarsi. Era un cadavere ambulante, un fascio di funzioni
fisiche ormai in agonia. Dobbiamo, per quanto dolorosa ci appaia la
scelta, escluderlo dalle nostre considerazioni. Io non posso che prendere
lo spunto dalla mia condizione personale, dalla condizione di un
prigioniero che pativa la fame ma non moriva di fame, che veniva percosso
ma non ucciso di botte, che era ferito, ma non mortalmente, che quindi
oggettivamente ancora possedeva quel sostrato sul quale in linea di
principio lo spirito può poggiare e sopravvivere. Poggiava, non vi è
dubbio, su fragili basi e sopravviveva malamente: e questa è tutta la
triste verità. Ho già accennato al fallimento o meglio al dissolversi di
catene associative e reminiscenze estetiche. Nella maggior parte dei casi
non rappresentavano una consolazione, talvolta apparivano dolorose e
beffarde; il più delle volte si disperdevano in un sentimento di assoluta
indifferenza.
Le
eccezioni si verificavano in determinati momenti di ebbrezza. Penso a
quella volta che un infermiere mi regalò un piatto di semolino dolce che
divorai voracemente, raggiungendo uno stato di straordinaria euforia
spirituale. Con profonda commozione pensai dapprima al fenomeno della bontà
umana, al quale associai l'immagine del probo Joachim Ziemssen, un
personaggio della Montagna incantata di Thomas Mann. E
improvvisamente la mia coscienza si colmò caoticamente del contenuto di
libri, di frammenti musicali, e riflessioni filosofiche che mi apparivano
come mia produzione originale. Investito da un impetuoso desiderio di
spiritualità e da un penetrante senso di autocompassione, proruppi in
lacrime. Uno strato non offuscato della mia coscienza era tuttavia
perfettamente consapevole del carattere fallace di questa breve
esaltazione spirituale. Si trattava di un vero e proprio stato di
ebbrezza, provocato da un fattore fisico. In colloqui avuti
successivamente con compagni ho potuto constatare che non fui l'unico a
vivere, in situazioni analoghe un breve momento di conforto spirituale.
Anche nei miei compagni di sventura si verificarono spesso simili stati di
ebbrezza provocati dal cibo o da un'ormai rara sigaretta. Come ogni
ebbrezza, lasciavano dietro di sé un desolante sentimento di vuoto e di
vergogna.
[Jean Amery, Intellettuale a Auschwitz (1966), Torino, Bollati Boringhieri, 1987]
Spunti
per la riflessione
1.
Chi era il "Muselmann" nel Lager?
2.
Perché risulta impossibile all'internato conservare una propria vita
interiore di sentimenti e di valori?
3.
Che significato si deve attribuire al piatto di semolino dolce di cui
parla Améry? Perché è così importante nella sua esperienza?
4.
Il racconto si conclude alludendo ad un sentimento "di vuoto e di
vergogna". Perché?