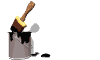Muhammad all'inferno
Solitamente
si sostiene che l’episodio di Muhammad, in cui la violenza realistica
della rappresentazione tocca uno dei suoi culmini in tutta l’opera di
Dante, sia ispirato esclusivamente all’immagine che di Muhammad aveva
tracciato la leggenda in Occidente, argomento appena accennato, ma
magistralmente analizzato da Alessandro D’Ancona nel secondo volume dei
suoi "Studi di critica e storia letteraria", Bologna 1912.
Secondo noi, chi avanza questa tesi, più che giustificare l’operato di
Dante, inconsapevolmente, lo scredita, evidenziando due aspetti del tutto
estranei, o meglio sconosciuti, del comportamento e della personalità del
fiorentino:
1.
Dante cade nella trappola della voce popolare e in
un errore grossolano, ignorando chi fosse il Profeta, nonostante la fama e
il rispetto di cui godeva Muhammad anche da parte di giuristi insigni come
il Buoncompagni che in pieno Duecento, nella vicina Bologna, ricordava il
Profeta fra le fonti giuridiche del "De origine iuris".
2.
Dante inserisce l’episodio volutamente
all’interno di un canto irto e tortuoso, con la sola intenzione di
lusingare qualche suo contemporaneo, assetato di vendetta contro quell’invidioso
e malvagio prete, anzi cardinale, che scatena lo scisma per rancore a
causa della sua mancata elezione al papato, o per soddisfare altre sue
basse passioni.
In
tutte e due le ipotesi Dante dimostrerebbe limiti e debolezze inconsueti
(salvo con la Chiesa, ovviamente), assumendo per di più un atteggiamento
quanto mai negativo e oltraggioso nei riguardi dell’islam. Tuttavia non
si capisce perché Dante l’avverroista, stimatore, senza mai
manifestarlo, della cultura arabo-islamica, uomo solitamente indulgente,
abbia voluto fornire di Muhammad l’immagine più rozza e più realistica
della Commedia. Che Dante fosse incorso in un banale errore e ignorasse
chi fosse Muhammad, non è opinione affatto credibile, se non altro perché
sarebbe lesiva della sua intelligenza e offensiva per il suo alto ingegno.
Né tanto meno risulta facilmente accettabile il fatto che Dante avesse
voluto scendere a quel bassissimo livello, sì da offrire quel carname
dilaniato (introdotto da una volgarissima similitudine) solo per appagare
il desiderio di qualche suo contemporaneo assetato di sangue saraceno. In
questa sede volgiamo avanzare una ipotesi mai azzardata e suggestiva, ma
probabilmente più aderente a quello stato psicologico che potremmo
chiamare "sindrome del debitore". E’ senz’altro un luogo
comune, particolarmente nella letteratura umoristica: la violenta
antipatia che caratterizza il personaggio del creditore. Colui verso il
quale si è in debito è sempre, e con una costanza impressionante,
persona odiata; particolarmente se il creditore, come in questo caso, è
un corpo estraneo, rifiutato dalla coscienza della collettività, odiato
dalle stesse istituzioni politiche, sociali, culturali e religiose. Anzi,
l’accanimento contro il creditore in queste condizioni diventa un dovere
quasi morale e un obbligo per la sopravvivenza in quella società. Nel
trattamento atroce, volgare e violento, anche nel linguaggio che Dante
riserva ingiustificatamente al Profeta, di cui peraltro non rivela la vera
identità, ma lo accomuna ad un oscuro e altrimenti ignoto personaggio, il
novarese Fra Dolcino, ci sembra si possa insinuare un sospetto di
"sindrome del debitore". Quanto deve l’Occidente all’islam?
E quanto deve lo stesso Dante alla cultura arabo-islamica? Non è questa
la sede opportuna per affrontare questa pagina della storia
dell’occidente: per quanto riguarda Dante, basterà leggere
"L’escatologia islamica nella Divina Commedia" (ora tradotta
anche in italiano) che l’insigne arabista spagnolo Miguel Asin Palacios
scrisse già in epoca non sospetta, siamo nel 1919, per dimostrare la
diretta dipendenza dell’impianto della Commedia dalla visione del
profeta Muhammad e del suo viaggio nei regni dell’oltretomba, noto come
"Libro della Scala", ipotesi poi suffragata dalle ricerche di
Enrico Cerulli che, oltre ad essere l’editore delle tre versioni del
Libro della Scala - in catalano, francese e latino, fatte in Spagna per
ordine di Alfonso X il Savio -, in un discorso "pronunziato nel
Salone dei Duecento del Palazzo della Signoria in Firenze" il 31
maggio 1956 indicò nel senese Bonaventura, notaio e scrivano di re
Alfonso, il traduttore delle due versioni latina e francese, già in
circolazione in Toscana fin dalla seconda metà del Duecento. Sfugge a
questa norma e non senza motivi plausibili, il Saladino. La generosità
era, com’è noto, considerata nel Medioevo, almeno tra i poeti e per
motivi facili da intuire, come la virtù dei principi. Infatti quella che
si attribuisce, e non senza ragione, al Saladino nella poesia medioevale,
lo rese celebre quasi alla stregua di Alessandro. Anche Dante non è
estraneo a questa consuetudine, esclama infatti nel "Convivio",
IV, XI 14: "E cui non è ancora
nel cuore di Alessandro per li suoi reali benefici? Cui non è ancora lo
buono re di Castella o il Saladino o il buono Marchese di Monferrato..."
Ed è assai probabile che, per questa stessa considerazione, Dante abbia
collocato nel Limbo il Saladino, il solo dei musulmani, in mezzo agli eroi
dell’antichità risparmiati dal vero inferno:
E
solo in parte, vidi ‘l Saladino (Inf. IV, 129)
A
dire il vero il Saladino non è l’unico musulmano risparmiato
dall’inferno dantesco. Anche Avicenna e Averroè "che il gran
commento feo", per altri motivi, sicuramente più nobili della
generosità dei principi, trovano posto nel Limbo fra "li spiriti
magni" che "sovra ‘l verde smalto... con occhi tardi e
gravi... parlavano rado, con voci soavi" insieme al "maestro di
color che sanno", cioè Aristotele. (Inf. IV, 143-44). Dante comunque
non risparmia dal suo Inferno chiunque si sia avvicinato alla cultura
arabo-islamica; basti ricordare la sorte di Michele Scotto (Michael Scott),
il filosofo e scienziato scozzese celebre per le sue traduzioni
dall’arabo in latino di parecchi libri dello Stagirita e di un compendio
aristotelico di Avicenna e per i suoi studi di alchimia, condannato alla
quarta bolgia dell’Inferno, quella degli indovini, dove i dannati hanno
la testa capovolta e con passi lenti e stentati camminano all’indietro.
Nemmeno papa Silvestro II (Gerberto, il Franco), reo di aver frequentato
la cultura arabo-islamica "fonte di tutti i mali", sfugge al
duro giudizio di Dante, che lo ricorda addirittura come consigliere di
frode.
Del
resto anche Bertrand de Born, signore del Castello di Hautfort in
Guascogna, poeta provenzale del XII secolo, ricordato da Dante nel
Convivio (IV.xi.14) tra i più grandi uomini degni di onore e nel "De
Vulgari Eloquentia" tra i grandi cantori della lirica eroica, Dante
infligge, alla fine dello stesso canto, la mutilazione più straordinaria
di ogni altra e, aggiungiamo, più di ogni altra atroce e sconcia. Anzi
sembra che l’architettura di tutto il canto, nella sua progressione di
scenari orrendi di "sangue e piaghe", porti volutamente a
culminare nella rappresentazione di Bertrand de Born. Anche qui, come
nell’episodio di Muhammad nulla ricorda il poeta provenzale della sua
poesia eroica, dei suoi serventesi, ma solo di una presunta colpa
scismatica che, francamente non giustifica in nessun modo quella terribile
pena del contropatimento. Qui ci chiediamo, e ci sembra che la domanda sia
d’obbligo, quali sono i reali motivi che hanno spinto Dante a
raffigurare in questa raccapricciante e esemplare mutilazione il tanto
celebrato e lodato cantore delle armi del De Vulgari Eloquentia. Più di
un critico ha voluto vedere nel canto XXVIII dell’Inferno un canto
epico. Ma basterà l’insistenza dell’esordio sullo spettacolo
raccapricciante dei campi di battaglia gremiti di cadaveri e di ossami e
la chiusa, ricollegata simmetricamente all’esordio sull’eccezionalità
dello spettacolo, a dimostrare il carattere epico del canto? Noi, invece,
vediamo nell’accanimento di Dante contro il poeta provenzale lo stesso
motivo psicologico che abbiamo supposto per Muhammad. Dante non è cantore
di armi, non è poeta epico e, se è vero che avesse tentato di fare
poesia epica in cinque canti dell’Inferno, dal XXVI al XXX, come
asserisce qualche insigne critico, Bertran de Born, stimatissimo poeta
delle armi, è stato certamente una fonte preziosa e un modello a cui
Dante si è ispirato. Ed è in questa chiave che si scatena il meccanismo
del fiorentino quello stato di rabbia e di ira contro il
"creditore". Comportamento identico e, se si vuole anche
simmetrico, con quello dell’esordio con Muhammad. La nostra è
ovviamente una mera ipotesi, una delle tante avanzate nel tentativo di
gettare luce su questo oscuro, intricatissimo canto; è una ipotesi tutta
ancora da discutere, da vagliare e da verificare, ma è soprattutto un
invito agli amici musulmani di accantonare quel senso di frustrazione e di
offesa che finora ha caratterizzato la loro reazione alla lettura del
canto XXVIII dell’Inferno. E’ un invito a vedere quell’episodio, non
l’offesa recata al Profeta, ma lo stato di inferiorità di Dante che
egli stesso, per inconscia ammirazione e per intima gratitudine, lascia
trasparire dalla noncuranza e perfino dall’ironia dell’atteggiamento
di Muhammad e, più ancora, dalla fierezza della sua risposta, spavalda e
insieme superba:
..."or vedi com’io mi dilacco!
Vedi come storpiato è M a o m e t t o!"
La
posizione del nome, alla fine del verso, suona alto in tutta l’imponenza
della sua larga sillabazione e suscita infiniti significati. Ma questi due
versi, secondo noi, suggeriscono una sola interpretazione "Saziati
pure alla vista del mio carname, ma ricordati chi sono io: M a o m e t t
o, qui non fiaccato dal martirio, su in terra venerato da milioni di
uomini, che riempiono il mondo con la loro fede e la loro scienza".
Con
l’Umanesimo il periodo detto della "cultura araba", venne
considerato un’epoca di barbarie, responsabile dell’adulterazione
dell’ideale dell’antichità greco-romana, della quale occorreva
riappropriarsi per assumerla come modello. Singolare può apparire che tra
i protagonisti di una simile "crociata" si trovi pure uno dei
padri fondatori dell’Umanesimo letterario, Francesco Petrarca. Non solo
il Petrarca esprime con vigore la sua avversione per lo stile dei poeti
arabi - a lui per altro completamente sconosciuti - ma nelle "Invective
contra medicum", scritto nel 1352 in risposta ad un medico avignonese
che curava Papa Clemente VI, si scaglia violentemente contro i fisici suoi
contemporanei, accusandoli di dipendere troppo dalla scienza araba in cui
stava "la fonte di tutti i mali". Il Petrarca vedeva nel medico
avignonese un suo nemico capitale, non solo l’antiumanista, ma
soprattutto lo scienziato avverroista. Era il periodo della "guerra
di religione", della lotta fra le due concezioni di vita, fra le due
culture, fra le due tendenze dello spirito umano, che continuano tuttora a
scontrarsi, sia pure su diversi livelli. Ma era anche il periodo in cui,
mescolando scienze e religione, era notevolmente sentita la necessità di
cancellare quegli "effetti nefasti" della scienza islamica che
aveva caratterizzato il duecento, detto appunto "il secolo
arabo" o "il secolo senza Roma".
E
con questa netta avversione dell’umanista Petrarca per la cultura
arabo-islamica cala praticamente il sipario sul mondo dell’islam fino ai
nostri giorni. Ciò non significa affatto che sono mancati i contatti fra
l’Europa e il mondo dell’Islam. Anzi i rapporti non sono mai cessati,
neppure le ostilità - le cosiddette crociate durano fino al Settecento -,
mentre è più recente la guerra contro l’Impero Ottomano, per non
parlare dell’occupazione militare europea di vasti territori di paesi a
maggioranza islamica e il perdurante colonialismo economico e culturale
che investe la totalità dei paesi dove si confessa la fede islamica. Ma,
al di là dei luoghi comuni, della ricerca dell’esotico e del
misterioso, l’Europa non ha mai cercato di capire realmente l’islam
nella pluralità del suo pensiero, il suo messaggio, la sua cultura e la
sua civiltà.