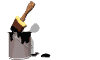|
|
NUOVE PROPOSTE DI LETTURA
SULL’OPERA DI G. LEOPARDI (queste note sono una rielaborazione da Elio Gioanola, Leopardi, la malinconia, Jaca Book, Milano 1995)
|
testo in Word
|
|
|
1.
Psicologia e poesia: 1819
Partendo
dalla constatazione che vissuto, poetica e ideologia formano un tutt’uno
armonico, mi sembra opportuno porre all'inizio di queste riflessioni la
data del 1819 come momento di svolta dell'arte e della filosofia
leopardiana. E' lo stesso Leopardi a rendersi conto della centralità di
questo scorcio temporale (lo testimoniano le lettere e le pagine dello Zibaldone,
oltre che, ovviamente, i suoi versi).
Per
capirne l'importanza, facciamo un excursus sull'ambiente
familiare[1].
Essere figlio di Monaldo e di Adelaide
Antici non era certo la cosa più piacevole del mondo. Il padre, o
meglio la sua figura simbolica, ha accompagnato Giacomo per tutta la
vita, tanto che senza il padre per lui risulta impossibile vivere. In
termini di dinamiche psicologiche, Monaldo rappresenta, per il figlio,
un tiranno (e ciò, dati i tempi, è anche normale), ma si tratta di un
tiranno buono, situazione, questa, che, nonostante le apparenze, aggrava
il quadro, perché (come insegnano Freud e tanti altri) il bambino
diventa adulto solo quando uccide (metaforicamente) il padre-tiranno[2].
Ora, se il tiranno è buono – e la fama di Monaldo come di un buon
padre di famiglia era ben nota presso i conoscenti: ma questi sono i
paradossi della vita! –, con che coraggio lo si potrebbe uccidere? E
infatti Giacomo non l'ha ucciso, anzi è morto prima di lui, e non solo
anagraficamente. Sulla madre Adelaide cito un solo episodio[3]
(ricordato dallo stesso Giacomo in Zibaldone 353-355): per
effetto del suo cristianesimo, retrivo al limite del patologico (anzi,
dello psicopatologico!), arrivava a sostenere che era meglio per i suoi
figli morire da piccoli per poter così essere sicuri di andare in
Paradiso (sic!). Questo fatto contribuì non poco a far nascere e
crescere in Giacomo, il quale effettivamente vide molti suoi fratellini
morire piccoli, la convinzione che vivere fosse una colpa; da qui
l'esigenza di una vita virtuosa e da qui anche il rafforzamento della
malinconia: devo essere virtuoso perché so di non valere niente.
Torniamo
al 1819. Come si sa, questa data segna due episodi, uno esterno e uno
interno: il tentativo di fuga da Recanati e la conversione filosofica.
Soffermiamoci sul primo, intanto. Il tentativo di fuga trova la sua
attuazione pratica nel luglio del 1819, quando il Leopardi aveva da un
mese compiuto i ventuno anni: si tratta del passaggio alla maggiore età,
cosa che consentirebbe a Giacomo di possedere un passaporto e spostarsi
così liberamente. E tuttavia non si capirebbe l'episodio senza tener
presente il ruolo svolto da Piero Giordani. E' noto che tra i due si
sviluppò un intenso scambio epistolare a partire dal 1817: il giovane
Leopardi aveva inviato la sua traduzione del II libro dell'Iliade
a Vincenzo Monti, ad Angelo Maj e al Giordani (rappresentanti,
rispettivamente, della poesia, della filologia e della prosa: fu proprio
quest'ultimo a rispondere in termini entusiastici)[4].
Le lettere del Giordani rappresentarono per Leopardi l'unico modo per
uscire dal suo isolamento (è chiaro che Giacomo aveva idealizzato la
figura di Piero): ai suoi occhi il piacentino rappresentava la
letteratura, la sete di gloria, il gusto del bello, tutti elementi che
il Leopardi aveva posto come méta da raggiungere dopo la prima
conversione, quella del 1816, che segna il passaggio dalla filologia[5]
alla letteratura.
Per
effetto della corrispondenza con il Giordani, in Leopardi si sviluppa
una dicotomia interiore che lo porta ad identificare Recanati come il
luogo della malinconia, dell'assenza del bello e della letteratura,
mentre il “fuori” è il luogo della salute, della fama, della gloria
letteraria[6].
Nel settembre del 1818 il Giordani giunge finalmente, dopo reiterati
inviti, a casa Leopardi, dove trova il suo giovane amico ancora vestito
con l'abito talare che indossava fin da piccolo: sono giorni di grande
fervore per Giacomo che ha l'occasione, per la prima volta nella sua
vita, di recarsi a Macerata (nientemeno!). È però certo che la
presenza fisica del Giordani rompe certi equilibri tra padre e figlio:
mentre il secondo si convince sempre di più della necessità di
lasciare le angustie recanatesi e familiari, l'altro non esita a pensare
che il famoso letterato sia la rovina dei suoi figli[7].
Per Monaldo il Giordani rappresentava il diavolo, perché con lui erano
entrati in casa sua il liberismo, l'italianismo (siamo nello Stato
Pontificio, non si dimentichi!), la letteratura "nuda" (cioè
senza un fine utilitaristico-pedagogico).
C'è
anche da notare che il Giordani, accortosi del fermo desiderio di
Giacomo di uscire da Recanati, si spaventò non poco, perché era
convinto che si sarebbe recato da lui costringendolo a divenirne il
responsabile, tanto che non esitò anch'egli a consigliare a Giacomo
l'Accademia Ecclesiastica per la quale faceva pressioni lo zio Carlo
Antici. In ogni caso, il Giordani fu il primo a riconoscere la grandezza
di Leopardi, come testimonia questa sua lettera all'editore Brighenti:
«Quando saremo insieme a
quelle nostre confidenze, colle canzoni alla mano[8]
spero che potrò giustificare la mia ammirazione per l'ingegno del
Leopardi, che proprio mi pare stupendo; e la fortuna del Monti è che ha
45 anni più dell'altro. Ma se Leopardi campa e se Monti fosse giovane
anch'egli, credetemi che Leopardi sarebbe un sole che eclisserebbe
tutti. Crediatemi (ma tenetelo in confessione) che Monti, Perticari, Maj
(e se credete che il signor Giordani sia qualche cosa), riuniti tutti
insieme, non fanno la metà dell'ingegno e del sapere di questo
giovane di ventuno anni. Dategli solo dieci anni di vita e di sanità e
tiratelo fuori degli orrori in cui vive, e ditemi il primo coglione
della terra, da Adamo in qua, se nel 1830 in Italia e in Europa non si
dirà che pochi Italiani (nei secoli più felici) furono paragonabili al
Leopardi».
L'episodio
del fallimento della tentata fuga è assai significativo. Il passaporto,
che doveva essere recapitato a Giacomo in persona, capitò invece (e non
a caso) nelle mani del padre, il quale, ancora una volta, si comportò
da tiranno-buono. Dandogli il passaporto, gli disse: "Se vuoi
parti!". In termini psicologici, questa si chiama "tattica
del doppio vincolo", per effetto della quale lo invita a
partire, ma al tempo stesso lo trattiene. E Giacomo lo capisce fin
troppo bene, quando scrive: «Io non esco s'egli mi apre le porte, ma se me le chiude: e mio padre
se n'è ben avveduto e perciò mostra di non oppormi nessun ostacolo. Ma
il cercare di ingannarmi non è aprirmi le porte e io lo considero fin
da ora come un nuovo chiavistello».
Abbiamo
qui a che fare con un vero e proprio psicodramma: l'impossibilità di
ribellarsi e di dimostrare di essere diventato un uomo produce in
Giacomo un ulteriore aumento della malinconia, che si esprime nella sua
forma classica: la disistima di sé[9];
in altre parole, Giacomo si convince che l'esistenza virtuosa non gli si
addice più: «Io sono stato sempre
spasimato dalla virtù: quello che io voleva eseguire non era delitto:
ma io son capace anche della colpa. Si vergognino che io possa dire che
la virtù m'è sempre stata inutile. Il calore e la forza dei miei
sentimenti si poteano dirigere a bene, ma se vorranno rivorgerli a male,
l'otterranno. E' gran tempo che io so qual'è la via d'essere meno
infelice in questo mondo, e ne vedo gli esempi in questa stessa città.
Non mi costringano ad entrarvi. Non fo gran conto di me: pur mi parrà
sempre formidabile chi avendo amata la virtù da che nacque, si consegna
disperatamente alla colpa». Ecco perché è così importante questo episodio della fallita fuga:
esso rappresenta il punto di svolta, cioè la conversione filosofica[10],
il passaggio dalla disperazione attiva a quella inerte (sono parole
sue), il che significa che non esiste più nemmeno la disperazione, ma
solo il vuoto, la noia, la malinconia. Lo scrive
al Giordani: «Sono
così stordito dal niente che mi circonda che non so come abbia la forza
di prender la penna per rispondere alla tua. Se in questo momento
impazzissi, io credo che la mia pazzia sarebbe di seder sempre con gli
occhi attoniti, colla bocca aperta, con le mani tra le ginocchia, senza
ridere né piangere, né muovermi altro che per forza dal luogo dove mi
trovassi[11].
Non ho più lena di concepire nessun desiderio, né anche la morte, non
perché io la tema in nessun conto, ma non vedo più divario tra la
morte e questa mia vita dove non viene più a consolarmi nemmeno il
dolore. Questa è la prima volta che la noia non solamente mi opprime e
stanca, ma mi affanna e lacera come un dolor gravissimo; e sono così
spaventato dalla vanità di tutte le cose e della condizione degli
uomini, morte di tutte le passioni, come sono spente nell'animo mio, che
ne vo fuori di me, considerando ch'è un niente anche la mia
disperazione».
Da
quanto s'è detto, si capisce come il 1819 rappresenti lo spartiacque
non solo per il Leopardi uomo, ma anche per il Leopardi poeta e
filosofo: la fallita fuga coincide con il fallimento delle speranze,
viene meno la voglia di combattere, svanisce l'azione e subentra il ghiaccio
e il deserto. Per capirlo, basta confrontare le prime due canzoni
con Bruto e Saffo: mentre in All'Italia Leopardi poteva dire L'armi,
qua l'armi: io solo / combatterò, procomberò sol io (vv.
36-37), in Saffo dice virtù non luce in disadorno ammanto
(v. 54), e sottentra il morbo e la vecchiezza e l'ombra / della gelida
morte (v. 67-68). Ora, da cosa nasce l'idea dell'infinito se non dal
rifiuto dell'azione (sul Tabor egli sta immobile)? E, in secondo luogo,
perché negli Idilli non ci sono verbi al futuro, ma sempre verbi
"esistenziali", se non quelli che hanno a che fare con l'idea
della morte e della distruzione[12]?
E allora si capisce anche perché il vero Leopardi, quello che è
diventato uno dei più grandi poeti e pensatori della storia, cominci
solo dopo la tentata fuga, solo dopo la caduta delle illusioni (un tema
questo che attraversa tutta la sua lirica).
2.
L'Infinito: testo archetipico
Il
periodo della «grande glaciazione», del «deserto» si apre con la
stesura de L'infinito (e di Alla luna, testo gemello), nel
settembre 1819, quindi qualche mese dopo la tentata fuga. Spero di
mostrare come questi 15 versi rappresentino il "cuore" di
tutta la poetica leopardiana, l'archetipo appunto.
Il
1 luglio 1820 Leopardi scrive nello Zibaldone: «Nella carriera politica il mio spirito ha percorso lo stesso stadio
che lo spirito umano in generale. Da principio il mio forte era la
fantasia e i miei versi erano pieni di immagini, e delle mie letture
poetiche io cercava sempre di profittare riguardo all'immaginazione. Io
era bensì sensibilissimo anche agli affetti, ma esprimerli in poesia
non sapeva. Non aveva ancora meditato intorno alle cose, e della
filosofia non aveva che un barlume (...) Sono sempre stato sventurato,
ma le mie sventure di allora erano piene di vita e mi disperavano perché
mi pareva che m'impedissero la felicità, della quale gli altri credea
che godessero. Insomma il mio stato era in tutto e per tutto come quello
degli antichi (...) La mutazione totale avvenni in me, e il passaggio
dallo stato antico al moderno, seguì si può dire dentro un anno, cioè
nel 1819 dove, privato dell'uso della vista e della continua distrazione
della lettura, cominciai ad abbandonare la speranza, a riflettere
profondamente sulle cose (...), a diventare filosofo di professione
(da poeta che io era), a sentire l'infelicità certa del mondo, in luogo
di conoscerla, e questo anche per uno stato di languore
corporale, che tanto più mi allontanava dagli antichi e mi avvicinava
ai moderni. Allora l'immaginazione in me fu sommamente infiacchita, e
quantumque la facoltà dell'invenzione allora appunto crescesse in me
grandemente, anzi quasi cominciasse, verteva però principalmente sopra
affari di prosa o sopra poesie sentimentali. E s'io mi metteva a fare
versi, le immagini mi venivano a sommo stento, anzi la fantasia era
quasi disseccata; bensì quei versi traboccavano di sentimento».
Da queste parole, di una consapevolezza sconvolgente, si vede
chiaramente l'infiacchimento dell'immaginazione e il conseguente
passaggio dalla poesia alla "filosofia": per uno scherzo del
destino, il Leopardi diventa vero poeta quando afferma di non esserlo più!
Già
nel Discorso sopra lo stato presente dei costumi italiani si vede
l'identificazione della poesia con la natura e l'opposizione natura vs
ragione. Cos'è la poesia contemporanea? In cosa consiste? In un
primo momento, Leopardi sostiene che essa nasce dall'immaginazione sul
modello degli antichi, anche se il loro mondo è ormai passato.
L'esigenza leopardiana è di evitare due pericoli (pericoli per lui,
ovvio!): lo scadimento nel patetismo tipico dei Romantici e il cedimento
al potere della pura ragione. E tuttavia, la crisi del 1819 lo convince
che la poesia d’immaginazione è finita per sempre; da qui
l'impossibilità dei moderni di produrre poesia immaginativa a tutto
vantaggio della poesia sentimentale. Bisogna però anche precisare che,
secondo il Leopardi, la poesia sentimentale non è la "poesia dei
sentimenti" (come per i Romantici), ma poesia del puro sentire,
della sensibilità, una poesia che nasce dall'angoscia dell'inappartenenza
esistenziale (lo "stato di languore" di cui ha parlato sopra).
La sensibilità è fonte di poesia; più ancora, è presa di coscienza
della vita come assoluta assenza in rapporto con la malinconia[13].
Si rafforza in lui la convinzione che la poesia moderna non possa che
essere "malinconica". Qui sta la differenza tra il
Romanticismo e Leopardi: per quest'ultimo la vita è il luogo
dell'assenza, mentre per i Romantici la vita è "piena" di
sentimenti; per l'uno la poesia nasce dal sentimento malinconico
dell'assenza, per gli altri nasce da una specie di
"affollamento" di svariati sentimenti.
C'è
un'altra considerazione che merita di essere menzionata. Leopardi è
convinto, a ragione anche questa volta, che la poesia antica nasca da un
vero e proprio atto di creazione, cioè una nuova forma di vita, un
mondo che prima non c'era, mentre la poesia moderna dipende dal
razionale il quale ha distrutto le illusioni che sono la "materia
prima" del poeta[14].
A dimostrazione della validità di questa disamina, F. Nietzsche
(finissimo lettore del Leopardi), qualche decennio dopo, dimostrerà che
solo per il mondo antico è possibile parlare di cultura (nel
senso proprio di creazione ex novo di qualcosa che prima non
esisteva), mentre il mondo moderno (diciamo dal Cinquecento in poi)
conosce soltanto (e non può essere diversamente) la critica della
cultura. Merito di Leopardi è di aver compreso che la poesia
immaginativa è finita per sempre: chi ancora vi indugia è fuori dalla
modernità. Il motivo mi sembra chiaro: il sentimento non è imitabile[15].
A
questo punto, stando a ciò che dice Leopardi, L'infinito o non
è poesia oppure è poesia di un genere assolutamente nuovo (in effetti
non obbedisce ad alcun tipo di progetto). In Zibaldone 1861si
dice: «Tali
lontane rimembranze, quanto dolci, tanto separate dalla nostra vita
presente, ispirando della poesia ec., non ponno che ispirare poesia
malinconica, com'è naturale, trattandosi di ciò che si è perduto;
all'opposto degli antichi a cui tali immagini poteano ben fare minore
effetto a causa dell'abitudine, ma erano sempre proprie, presenti, né
mai si consideravano come cose perdute o riconosciute per vane; quindi
la loro poesia dovea esser lieta, come quella che verteva sopra dei beni
e delle dolcezze da loro ancor possedute e senza timore».
Da queste parole risulta, a conferma di quanto detto prima, che il
ricordo di ciò che si è perduto produce malinconia (cioè poesia
malinconica, cioè poesia moderna), mentre per gli antichi la poesia è
fonte di gioia. Ne L'infinito si tenta di toccare la sensibilità
allo stato puro[16],
già nel titolo: ciò significa andare oltre le cose come sono per noi
(il mondo fenomenico), anche le più care, per cogliere la cosa in
sé, il deserto da cui scompaiono i segni della vita. Ricordo
che per Leopardi la vita è rimpianto assoluto, è desiderio e oblazione
di desiderio[17].
L'idea
dell'infinito ha a che fare con la malinconia (in questo senso parlavo
archetipo). Ora, in Leopardi la malinconia non è una condizione
passeggera, come càpita a molti, ma, direi, esistenziale: ciò
che si è perso non è qualcosa del mondo fenomenico, ma la Cosa[18].
Essa è il mondo del non-simbolico, è il pre-linguaggio, è la perdita
originaria della madre; in altre parole, la Cosa è il reale che
si ribella alla significazione, è il tentativo di creare rapporti con
qualcosa di primordiale. Si tratta del Das Ding di cui parla
Heidegger, che, a sua volta, risale alla distinzione kantiana tra
fenomeno e noumeno, al Wille di Schopenhauer, e in definitiva al tò
pràgma autò («la cosa in sé») di Platone a cui Aristotele
opporrà la teoria del Primo Mobile. Per Leopardi la Cosa è la
Natura di cui ha un'irresistibile nostalgia; la Cosa implica
l'idea di infinito, è la Cosa che sta prima delle cose e delle
parole, è l'oggetto finito usato per indicare un oggetto infinito[19].
Sta tutto qui il rapporto tra malinconia e genialità: ripudiare il
desiderio per sublimare il desiderio stesso (il desiderio diventa
poesia); è un desiderio infinito e di infinito che nessun piacere
finito può appagare. La poesia nasce dal vuoto, dall'assenza, cioè dal
desiderio, ma ha la pienezza di una forma formata. La poesia moderna ha
a che fare con la parola indefinita e indeterminata[20].
Sulla
base di tutto ciò che si è detto, L'infinito è la ricerca
della Cosa perduta attraverso il "non-nominabile", cioè gli
elementi pre-linguistici (suono e ritmo). E' incredibile come il
Leopardi sia riuscito a dire tutto ciò in soli quindici versi, di
un'essenzialità unica. Lasciando da parte tutto ciò che si è scritto
su questo testo (fiumi di inchiostro!), soffermiamoci su due elementi
fondamentali, cioè il binomio sedendo e mirando. Per quanto
concerne il primo, ci si può chiedere perché il poeta sottolinei
questo particolare: non certo, come si potrebbe pensare, perché la
siepe è troppo bassa e quindi costringe a sedersi (sarebbe troppo
banale e Leopardi non è mai banale). In realtà, lo star seduto è la
posizione tipica del malinconico e, se ci si fa caso, il Leopardi degli Idilli
è un soggetto lirico seduto: con ciò si vuole indicare
l'abolizione dell'azione e del movimento che prelude al viaggio verso la
Cosa, cioè l'uscita dal mondo fenomenico. Come s'è detto sopra,
dopo il 1819 il Leopardi passa dalla poesia attiva a quella passiva del
richiamo verso la Cosa (profondissima quiete). Il sedendo
anticipa l'abolizione della spazio-temporalità e lo dice subito
l'iniziale Sempre: si tratta di un "presente onnivoro",
per effetto del quale ha senso solo l'essere, la stasi che
precede l'ex-stasis (questo è un testo mistico).
A
proposito di mirando, si sa che esso indica un vedere tutto
interiore[21]:
mirare (mondo noumenico) è il contrario di vedere (mondo
fenomenico); il mirare è accostamento alla Cosa. La poetica del
Leopardi è una poetica del mirare: c'è la realtà e la sua
trasfigurazione[22],
si va dalla presenza all'evento carico di senso. Nel vedere prevale
l'azione, nel mirare la contemplazione (io nel pensier mi fingo).
Dopo la Cosa c’è il silenzio, l'afasia.
Un'ultima
osservazione. L'annegare e il naufragare sono metafore
dell'estasi e il fatto che non compaiano più in seguito (sono infatti
degli hapax legòmena) indica l'unicità del testo: in effetti,
tranne che in Alla luna che può essere considerato un testo
gemello, il Leopardi non è più tornato sul tema, perché l'infinito si
coglie una volta sola. Cosa indica il naufragare se non la perdita della
fenomenicità? Non a caso, il naufragare leopardiano corrisponde, nel
linguaggio mistico, al contemptus mundi, cioè del transeunte,
del fenomenico. Si capisce anche perché al tema dell'infinito è
collegato quello della rimembranza[23]:
il ricordo è il luogo della Cosa. La rimembranza è un luogo
pieno di cose fenomeniche che, però, rimandano al noumenico: è un
andare verso la Cosa restando nelle cose[24]!
3.
La filosofia leopardiana: il metodo
La
filosofia leopardiana sta diventando parte integrante della
rivisitazione critica.
Dice
Julia Kristeeva[25]:
«la malinconia mi dà una lucidità
suprema, metafisica; alle frontiere della vita e della morte ho talvolta
il senso e la presunzione di essere testimone del non senso dell'essere;
il mio dolore è il volto nascosto della mia filosofia, il suo fratello
maggiore, muto. Per questo, il malinconico è naturaliter philosophus
e filosofo del nulla essere del nulla».
Noi sappiamo bene quanto il Leopardi si indignasse nel sentirsi imputare
il tenore della sua filosofia alle sue condisioni fisiche e
psicologiche, tanto che è diventato un luogo comune dire
"pessimista perché malato".
Qui
si pone il problema: come è possibile collegare condizione malinconica
con filosofia se lo stesso Leopardi invita a non commettere questo
errore? Nessuno dei moderni lettori del Leopardi fu libero dal pensare
che ci fosse un collegamento tra malattia malinconica e filosofia, come
non ne fu libero il primo lettore del Leopardi, F. De Sanctis, il quale
dice: "Questa non è ancora filosofia, è il cattivo germoglio
della disperazione, è la secrezione dell'umor nero" (tanto basta
per segnare il destino critico del Leopardi nel senso di una
svalutazione della sua filosofia!); "mancano al Leopardi le alte
qualità di un ingenio filosofico!". E' stato poi, come si sa, il
Croce ad estremizzare la posizione desanctissina, quando dice:
"Nell’intelletto del Leopardi si formava un giudizio che, a poco
a poco, prese veste di teoria filosofica, proeizione raziocinante del
proprio stato infelice" (senza commento!). Entrambi, come si vede,
collegano il pensiero del Leopardi alla sua malattia, con il risultato
di svalutarne il pensiero, dicendo: questo non è pensiero! Più
recentemente, si è assistito al fenomeno opposto, cioè si è sganciato
totalmente il pensiero leopardiano dalle circostanze concrete in cui è
nato (anche questa è un'operazione sbagliata!).
Quando
la Kristeeva dice che il malinconico è filosofo per vocazione, non per
questo significa che, ispo facto, egli sia in grado di convertire
creativamente, senza il misterioso dono della creatività, la propria
sofferenza: il malinconico è un filosofo esistenziale[26],
ma ciò non significa che sia un filosofo creativo, come il Leopardi,
nel quale la filosofia travalica la pura consequenzialità
malattita-filosofia, perché in Leopardi sussiste il misterioso dono
della genialità. Già Aristotele diceva che la malinconia produce la
genialità, così come il malumore, la malattia, la sofferenza[27].Ora,
se è vero che tutta la filosofia leopardiana può essere posta
all'insegna del negativo, in rapporto con la malinconia, ciò non
implica davvero la negatività e quindi l'insignificanza di quel
filosofare (come diceva Croce), perché «non da nulla è questa
filosofia del nulla!» (sono parole del Leopardi).
S.
Timpanaro dice: «La malattia dette al
Leopardi una coscienza particolarmente acuta e precoce del pesante
condizionamento che la natura esercita sull'uomo, dell'infelicità
dell'uomo come essere fisico, per cui essa è diventata un formidabile
strumento conoscitivo». Si tratta
però di uscire dal generico, dal momento che questa malattia ha un nome
e la filosofia possiede un'impronta autonoma e originale: la condizione
malinconica è un quadro di riferimento imprescindibile e il sistema
filosofico, fatta salva la genialità, non può non portare in sé il
codice genetico e il corredo fenomenologico di quello status
esistenziale di cui è sublimazione speculativa. Si pensi, per esempio,
al tema della noia e del nulla, così centrali nel Leopardi: qui c'è
davvero una consecuzione di omologie tra stile e contenuti del pathos,
cioè della sofferenza malinconica, e stile e contenuti del pensiero,
così che nulla sul piano del vissuto è senza senso in riferimento
all'opera e nulla nell'opera si dà senza concreto radicamento in quel
vissuto, al di là di ogni determinismo.
Da
ciò che si è detto, risulta chiaro come io mi stia muovendo in
un'ottica non culturalista: sono convinto che la condizione del Leopardi
così connotata sia l'asse portante attorno a cui gira l'intero universo
della sua opera e della sua filosofia, la quale è originale nella
misura in cui si dà come inedita creazione di stile, e questo ha
a che vedere con la configurazione complessiva dell'autore a partire
dalle prime esperienze psicologiche. E' solo a partire dalla
fenomenologia del vissuto che si può parlare non astrattamente (come ha
fatto benissimo il Timpanaro) del pensiero leopardiano. Siamo giunti
all'opposto di quanto sosteneva il Croce: se Leopardi non fosse stato
così, non sarebbe stato il Leopardi. Lo stesso concetto di ragione
non è tanto un prodotto dell'Illuminismo, come si dice spesso, quanto
piuttosto un prodotto di casa Leopardi: se ci si pensa bene,
specialmente dopo quanto si è detto, il razionalismo leopardiano è un
razionalismo monaldiano, cioè derivante a Giacomo dal padre
Monaldo, perché, a motivo dell'educazione ricevuta, il Leopardi non ha
sviluppato un Io autonomo, ma delle qualità, soprattutto
l'intelligenza: ciò è tipico del malinconico, di colui cioè che
dipende dagli altri (esattamente come Giacomo dipendeva dal padre).
La
ragione, sia come distruttrice dell'errore sia come assassina delle
illusioni (la strage delle illusioni), è il fondamento stesso
delle relazioni con il padre reale e con il padre fantasmatico, nella
devozione totale come nella rivolta impotente. Parlare allora di
ascendenza illuminista del pensiero leopardiano, con il suo corollario
di sensismo e di naturalismo, è qualcosa di astratto. La ragione è
originariamente e soprattutto monaldiana: in nome di essa il
ragazzo si è immolato, scoprendone il potere devastante quando il
distacco dal dominio paterno lo ha gettato nella malinconia; è stata la
devozione sacrificale al padre a fare di Giacomo una mente senza
corpo, e la malattia è cominciata con la disperata consapevolezza
di questa condizione, così che la ragione è stata fatta colpevole
della rovina nel momento stesso in cui la sua tirannia è diventata
ossessivamente una caratteristica stessa della malattia. La malinconia
può essere definita come pensiero dolente: il malinconico,
infatti, è uno che pensa troppo, è un pensatore in eccesso, che
trasforma tutto in pensiero. A 17 anni Leopardi scrive il Saggio
sopra gli errori popolari degli antichi: si tratta di un libro
monaldiano, cioè una demolizione, sulla base della ragione, di tutti
gli errori degli antichi, quindi di suo padre
[28].
Ciò è importante perché le due conversioni, quella del 1816 e quella
del 1819, hanno alla base il passaggio dalla devozione verso la ragione
alla consapevolezza che la ragione è colpevole di tutto, per cui
l'errore, che prima era considerato il peccato per eccellenza, diventa
il positivo: cosa sono, infatti, l'illusione e la fantasia se non un
"errore", cioè qualcosa che fa "errare"? Tutto
questo capovolgimento avviene senza mai uscire dall'universo monaldiano
che ha impiantato questa concezione. Ecco allora che l'Illuminismo
subentra solo in seconda istanza.
Quello
del Leopardi è stato definito pensiero dolente: ciò è giusto
perché nel malinconico il collasso della vitalità fa tutt'uno con
l'ipertrofia del razionale; e chi non vive, cioè non prova le
distrazioni potente dell'agire, non può fare altro che pensare –sino
al dolore mentale– e pensare alla propria condizione. L'attività del
malinconico (il pensiero) non può che essere negazione di quella stessa
attività (pensiero ridotto a se stesso e privo di ogni raccordo con
l'esteriorità). Leopardi diventa filosofo nella misura in cui si
afferma la sua malinconia, fino al punto di rottura rappresentato dalla
crisi del 1819, quando diventa, come dice lui, «filosofo di
professione da poeta che io era».
Certo,
anche la più filosofica della malattie, la malinconia, non basta a far
diventare filosofi di professione. Questa filosofia, che risulta così
nuova da far credere a Croce che fosse inesistente, attinge la propria
originalità dal costituirsi, a partire dall'ipertrofia patogena del
razionale, come teoria dello scacco della ragione nel trionfo del
razionalismo illuministico e idealistico, tra Kant ed Hegel. Conviene
allora soffermarsi sul nesso ragione-filosofia. Si tratta di due
termini facilmente sovrapponibili e il secondo tende ad assumere una
funzione di trascendimento rispetto al primo, cioè: dal momento che la
filosofia non può identificarsi, pena la sua distruzione, con l'oggetto
che intende distruggere (la ragione), non si può credere che la
filosofia leopardiana coincida con la ragione perché altrimenti,
siccome tutto il suo pensiero è volto verso la distruzione della
ragione, sarebbe lo stesso che morto alla distruzione della filosofia.
Al di là delle varie opposizioni (natura vs ragione, illusioni vs
realtà, sistema del bello vs sistema del vero), rimane ferma la
convinzione circa il potere distruttivo della ragione. Subito all'inizio
dello Zibaldone, infatti, Leopardi dice: «Qui
voglio notare come la ragione umana di cui facciamo tanta pompa sopra
gli altri animali, e nel cui perfezionamento facciamo consistere quello
dell'uomo, sia miserabile e incapace di farci non dico felici ma meno
infelici, anzi di condurci alla stessa saviezza che par tutta consistere
nell'uso intero della ragione (...) E' certissimo che tutto ciò che noi
facciamo lo facciamo in forza di una distrazione e di una dimenticanza,
la quale è contraria direttamente alla ragione. E tuttavia quella
sarebbe una verissima pazzia, ma la pazzia la più ragionevole della
terra, anzi la sola cosa ragionevole»[29].
Della ragione la filosofia mantiene tutte le caratteristiche negative e
in effetti i due termini sono dati come equivalenti e intercambiabili:
anche la filosofia impoverisce la vita, la rende brutta e monotona,
dissecca le fonti dell'immaginazione, induce all'inazione. Ragione e
filosofia realizzano il tipico tratto malinconico dell'assenza di
movimento[30].
A
questo punto, la domanda è: se ragione e filosofia sono entrambe
negative, che senso ha filosofare? Sembra che in un primo momento il
Leopardi non si renda conto di questa aporia, come il suo filosofare
sulla filosofia sia un trascendimento di fatto della pura negatività di
cui tratta. In effetti, non c'è sospetto di aporia fino a quando
ragione e filosofia sono dati come equivalenti e il binomio viene
contrapposto al mondo dell'immaginazione. Bisogna tener presente che
l'equivalenza ragione-filosofia vige fino a quando e nella misura in cui
Leopardi ha in mente la filosofia moderna che è essenzialmente critica,
cioè demolitrice delle credenze antiche e scopritrice del vero,
informandosi ai criteri della matematica e delle scienze[31].
Ma colui che si è fatto filosofo di professione e che fa filosofia
sugli effetti devastatori della filosofia fa presto ad accorgersi della
propria diversità rispetto ai veri filosofi di professione, perché in
qualche modo ha dovuto trascendere quella negatività per accorgersi di
essa e, per far questo, ha scosso l'identità tra ragione e filosofia.
In secondo luogo: se l'opposizione tra filosofia e poesia fosse
assoluta, l'una rappresentativa della modernità e l'altra del mondo
antico, perché gli antichi furono anche grandi filosofi? È su questo
punto che il Leopardi deve distinguere tra filosofia e filosofia, perché
c'è stato un tempo (l'antichità) in cui filosofare non significava
rinunciare all'immaginazione e all'azione: il filosofo antico era
creativo quanto il poeta[32],
perché il suo pensiero era sintetico e costruttivo, non analitico e
critico come quello dei moderni. Tutti i pensatori antichi facevano
della propria filosofia non una dottrina fredda, ma un modo di
interpretare la realtà, tanto da distinguersi dagli altri uomini per la
loro vita singolare (si pensi a Socrate e ai Cinici). In questo modo,
dice Leopardi, la filosofia antica era vicina al pensare primitivo,
affine alla natura: «Ogni
passo della sapienza moderna svelle un errore, ma non pianta niuna verità;
dunque se l'uomo non avesse errato sarebbe già sapientissimo. Ma chi
non ragiona non erra. Dunque, chi non ragiona o non pensa è
sapientissimo. Dunque sapientissimi furono gli uomini prima della
nascita della sapienza e del raziocinio sulle cose: sapientissimo è il
fanciullo e il selvaggio che non conosce il pensare"[33].
Per il Leopardi quindi il migliore filosofo è colui che non pensa. Per
uscire da questa situazione paradossale (non si può certo dire che i
filosofi antichi non pensassero!), bisogna mediare tra i due termini
dell'opposizione che di per sé conduce al paradosso: la mediazione
consiste nel disancorare la filosofia dalla coincidenza, tutta moderna,
con la ragione.
Qual
è allora la vera filosofia? Il razionalismo aristotelico o la filosofia
di Platone che include anche l'immaginazione? La domanda è parallela a
quella sulla vera poesia perché, come la poesia vera è quella antica,
così la vera filosofia è solo quella moderna, con la possibilità che
anche anticamente si potesse filosofare razionalmente (Aristotele e
seguaci) e che anche modernamente si possa fare poesia in termini di
sentimento. Si capisce quindi che il Leopardi, dopo aver puntato
sull'opposizione natura vs ragione, antico vs moderno,
poesia vs filosofia, è costretto a porsi domande sulla natura
del proprio filosofare, dal momento che si rende conto di essere sia
filosofo sia poeta. Ecco allora che Leopardi conia un termine molto
significativo: parla di ultrafilosofia. Essa è lo sforzo
di trascendimento della ragione pura, caratteristico di tutta la
speculazione leopardiana, costantemente alla ricerca di ciò che, sempre
nell'uso rigoroso degli strumenti razionali, valga a scuotere
l'identificazione tra ragione e filosofia. Il superamento di tale
identificazione non avviene in una mescolanza di poetico e di
filosofico, perché i due momenti sono ben distinti. Colui che è
diventato filosofo, in quanto vittima della ragione, ha cercato di
svincolare la propria filosofia dalla coincidenza con la ragione. Il
Leopardi dice chiaramente che sola la ultrafilosofia ci libera
dagli inganni della filosofia; da ciò il paradosso secondo cui «nessuno
è meno filosofo di chi vorrebbe tutto il mondo filosofo». Il vero
filosofo è, secondo Leopardi, colui che valorizza le proprie illusioni,
proprio in virtù del suo non essere illuso, mentre il filosofastro
combatte le illusioni proprio perché è un illuso. Insomma, il
filosofare si presenta a Leopardi come necessità di un superamento
dell'opposizione filosofia-poesia, al punto che il fondamento della
speculazione diventa la facoltà sensitiva; ne deriva che la filosofia
è per Leopardi la scienza della sensibilità, conoscenza intima
del cuore umano. Si tratta di un filosofare pre-esistenzialista (intendo
dire in anticipo rispetto all'esistenzialismo di Heidegger). Questo
spiega anche perché da molti la sua filosofia sia stata considerata una
non-filosofia, perché non è affatto una gnoseologia e neppure
un'etica: è una fenomenologia esistenziale!
Il
nesso filosofia-poesia, assolutamente centrale in Leopardi, è problema
metodologico assillante nella misura in cui deve dare conto di quell’irriducibile
"altro dalla ragione" che è la natura e la grande novità di
questa filosofia, così a lungo incompresa. La qualità tipica dell'ultrafilosofo
è quella che il Leopardi definisce il "colpo d'occhio", o
"genio", che significa partecipare della sensibilità e quindi
della vitalità della natura. Questo lampo rivelatore che dischiude
verità nascoste presuppone quelle virtù di sensibilità e
immaginazione che, trascendendo la ragione in quanto tale, costituiscono
la dote prima del grande poeta. Il vero filosofo immaginato da Leopardi
è tanto raro da rischiare l'inesistenza (il vero filosofo è lui e di
Leopardi ce n'è uno solo!). Tutto questo però non significa che poesia
e filosofia si identifichino e che mescolino il loro linguaggio (anche
se deriva dalla stessa fonte): chi si dedica alla speculazione deve
usare le armi del mestiere, facendosi "freddissimo
ragionatore" (com'era lui), anche se la sorgente della conoscenza
viene dalla sua natura di "ardentissimo poeta". E' lo stesso
Leopardi che spiega questo paradosso dicendo: «È
la contraddizione che involve in sé la ragione, la quale, per fare
grandi effetti e decisi progressi, ha bisogno di quelle stesse
disposizioni naturali che ella distrugge o ne è distrutta:
l'immaginazione e il sentimento».
È quindi sbagliato affermare che l'opposizione natura-ragione venga poi
risolta, perché l'opposizione resta, anche se sussiste un indissolubile
vincolo tra le due facce che la compongono. In effetti, come si è visto
sul piano del vissuto (§ 1) e su quello della poetica (§ 2), si tratta
degli strati di un'unica condizione esistenziale: è il fuoco del
desiderio e della nostalgia di vita, di cui si nutre la poesia, e il
ghiaccio della morte malinconica, di cui la ragione è il corrispettivo
(ecco di nuovo l'ossimoro ghiaccio-fuoco)[34].
4.
La filosofia leopardiana: una questione di stile
Dopo
quanto si è detto, ci si potrebbe chiedere se il Leopardi sia da
considerare un esponente della cultura moderna o non presenti piuttosto
una sorta di preumanesimo (o di antiumanesimo). Per rispondere bisogna
considerare che per lui i nomi che contano, quelli a cui si sente più
legato, sono proprio i fondatori del pensiero moderno: Machiavelli,
Galileo, Cartesio, Newton, Locke. Ne deriva che l'opposizione ragione vs
natura, positivo vs negativo non comporta un riflusso
preumanistico e oscurantista, perché il Leopardi introduce il concetto
intermedio di seconda natura: la ragione è la seconda natura
dell'uomo (si tratta dell'epoca moderna). In pratica, per il Leopardi
tra l'età della natura e quella della ragione c'è il passaggio
intermedio della barbarie, un'epoca, cioè, in cui non esiste più
la natura prima (la felicità originaria degli antichi), ma al
tempo stesso non esiste ancora la seconda natura: esiste solo
l'allegorico, il fantastico, la superstizione connessa con una filosofia
razionalista basata su premesse fantastiche (si tratta del Medioevo
aristotelico che il Leopardi considera età della barbarie). Il
pensatore moderno, invece, è colui che scopre il vero, la "verità
effettuale" di cui parla, come è noto, Machiavelli: questa è la seconda
natura («ancor che triste, ha i suoi vantaggi il vero!»,
dice Leopardi), cioè il vero come sistema filosofico. A dimostrazione
di ciò basterà citare (tra i tanti esempi) il Dialogo di Plotino e
Porfirio: quando Plotino sostiene che il suicidio è contro natura,
Porfirio ribatte: «quella natura
primitiva degli uomini antichi e delle leggi selvagge e incolte non è
più la nostra natura: ma l'assuefazione e la ragione hanno fatto in noi
un'altra natura; la quale noi abbiamo, ed avremo sempre, in luogo di
quella prima». La prima natura,
per cui il suicidio è illecito, non esiste più; di conseguenza, per la
seconda natura esso è lecito (anche se poi, come si sa, Porfirio –e
lo stesso Leopardi– non si suicida). La seconda natura,
insomma, è il minore dei mali possibili: dicendo questo, viene meno
l'interpretazione "progressiva" del Leopardi[35],
secondo la quale la Ginestra sarebbe l'atto conclusivo di un
percorso evolutivo, mentre queste cose il Leopardi le diceva già nel
1824[36]:
si può dire, certo, che il Leopardi sia progressivo, ma non nel senso
del progressismo settecentesco.
Abbiamo
visto come sia la linea idealista (Croce e seguaci) sia quella marxista
(Binni, Timpanaro, Luporini), abbiano travisato la filosofia
leopardiana, perché non sono riuscite a coglierne la grandezza (il
Leopardi non è né positivista né marxista), cioè lo snodo basilare,
che consiste nello stretto legame tra pensiero e poesia (la sua
è una poesia pensante e un pensiero poetante). A questo punto non ci
stupirà saper che gli unici a capire la filosofia leopardiana siano
stati gli irrazionalisti tedeschi, Shopenhauer e Nietzsche[37].
Che tra Leopardi, Shopenhauer e Nietzsche vi siano numerosi punti di
contatto non mette in conto dimostrare, essendo cosa nota per chi ha
letto le loro opere e ne conosca il pensiero. Mi soffermo solo (si fa
per dire!) sull'aspetto secondo me fondamentale: il concetto di stile,
che significa non solo modo di scrivere, ma anche modo di
pensare. Ora, sia Shopenhauer sia Nietzsche (come Leopardi) sono,
oltre che filosofi, anche grandi scrittori[38],
e lo sono perché dietro lo stile c'è il pensiero e il loro stile di
pensiero si traduce in una scrittura artistica, stile del pensiero e
pensiero sullo stile[39].
Come dice Shopenhauer: «La conoscenza geniale non segue il principio di
ragione: l'uomo di genio non è intelligente, è un selvaggio; il
filosofo ideale è colui che non pensa!». È proprio a partire da qui
che si capiscono i legami instaurati da Leopardi tra filosofia e poesia:
la filosofia è alleata della poesia e viceversa. Come per Schopenhauer
e Nietzsche, anche per Leopardi il principio di ogni conoscenza è
estetico, non teoretico: la parola è sostanza del pensiero e il
pensiero, a sua volta, è un problema di stile, prima ancora che di
conoscenza: conoscenza dello stile che diventa stile della conoscenza[40].
In Leopardi, la poesia non è solo il contenuto, ma anche la forma della
filosofia: «immaginazione e intelletto sono tutt'uno», dice
nello Zibaldone.
Prima
di terminare accenniamo a due pilastri del sistema leopardiano:
a)
assuefazione: indica l'acquisizione rispetto a ciò che è il
dato originario, vale a dire ciò che l'uomo impara, cioè la cultura.
«L'uomo è l'animale più assuefabile di tutti»[41].
In questo senso, che cos'è il talento se non la disponibilità a
contrarre abitudini e attitudini? L'uomo, dice Leopardi, è il prodotto
delle circostanze ambientali e delle manipolazioni che ha subìto[42].
Ne consegue che la filosofia leopardiana è radicata esistenzialmente (cfr.
§ 3) perché parte sempre dalla sua esperienza e per il fatto che porta
in sé le stimmate dell'impianto malinconico[43].
b)
relativismo: questo tema è legato strettamente al primo, perché,
se tutto è assuefazione, tutto è relativo, dal momento che tutto
dipende dai condizionamenti ambientali che ci hanno plasmato; di
conseguenza, se tutto è costruito, niente è innato. «Ella
è cosa certa e indubitabile: la verità, che una cosa sia buona, che
un'altra sia cattiva, vale a dire il bene e il male, si credono naturalmente
assoluti, e non sono altro che relativi. Questa è una fonte immensa di
errori, e volgari e filosofici. Questa è un'osservazione vastissima che
distrugge infiniti sistemi filosofici ec.; e appiana e toglie infinite
contraddizioni e difficoltà nella gran considerazione delle cose,
massimamente generale, e appartenente ai loro rapporti. Non v'è quasi
altra verità assoluta se non che Tutto è relativo. Questa dev'essere
la base di tutta la metafisica"[44].
Il relativismo comporta anche il crollo dell'idea di Dio («principio di tutte le cose e di Dio è il nulla»);
non si può tuttavia dire che Leopardi sia ateo, perché in lui c'è una
distinzione tra il Dio dei filosofi (in quanto idea) e il Dio di natura,
per cui anche il problema di Dio, come si vede, si sposta dalla ragione
alla natura[45].
Giova anche ricordare che il malinconico è naturalmente portato
all'ateismo perché la malinconia produce il collasso della speranza,
quindi della fede (che è, come dice Dante, sostanza di cose sperate),
quindi della carità.
[1] Per altre notizie, cfr. R. DAMIANI, Vita di Leopardi, Milano, Mondadori, 1992. [2] Si ricordi l'Ortis foscoliano; ma gli esempi sarebbero numerosi. [3] Altri se ne possono vedere in DAMIANI, op. cit. [4] Cfr. DAMIANI, cit., 103ss. [5] Si tenga presente che già a quindici anni il Leopardi era considerato uno dei filologi più eruditi d'Italia. [6] Non a caso, quando il padre gli dirà che "extra Recinetum nulla salus!", egli risponderà con un eloquente "extra Recinetum una salus!". [7] Questa posizione non stupisce se si pensa che Monaldo era un alfiere dell'educazione domestica, tanto da curare personalmente la formazione dei suoi figli, sul modello del Collegio gesuitico, in un periodo in cui la Societas Jesu era stata disciolta. [8] Si tratta di All'Italia e di Sopra il monumento di Dante. [9] Cfr. S. FREUD, Lutto e malinconia. [10] Mentre la prima conversione lo fa passare dalla filologia alla poesia di immaginazione, questa lo fa passare dalla poesia di immaginazione alla poesia di sentimento. [11] Faccio notare che questa è la tipica posizione del malinconico. [12] Si veda, per esempio, A se stesso. [13] Non è un caso, anzi è rivelatore, che Leopardi usi indifferentemente la definizione di "poesia sentimentale" e di "poesia malinconica", come dimostrano molti passi dello Zibaldone. [14] Da qui nasce l'identificazione poesia antica=natura; poesia moderna=ragione. [15] Si vedano in proposito le considerazioni dello Zibaldone, in data 8 marzo 1821. [16] Il tutto nasce, come detto, dal sentimento dell'assenza. [17] È necessario, in proposito, andare a vedere la leopardiana teoria del piacere, con il suo collegamento tra desiderio del piacere e infinito. [18] Si veda in proposito le riflessioni di J. Lacan, in La Chose, uno dei suoi Sèminaires, e quelle della sua allieva Julia Kristeeva, Il sole nero, tr. it., Milano, Feltrinelli. [19] Definizione diciamo noi appunto. De-finire = "smettere di dire il finito". [20] Si noti come Leopardi dica queste cose prima di Baudelaire, Pascoli, Ungaretti e compagnia! [21] Si veda lo studio di L. BLASUCCI, Leopardi e i segnali dell'infinito, Bologna, Il Mulino, 1985. [22] Tra l'altro, il monte Tabor è nell’evangelo il luogo in cui Gesù si trasfigura di fronte ai suoi discepoli i quali dicono appunto: "È bello per noi stare qui": [23] Si veda Alla luna. [24] Nonostante le apparenze, Leopardi non è mai realistico, neppure quando parla di "gallina tornata in su la via". [25] Il sole nero, op. cit. [26] I depressi non fanno altro che elencare la fenomenologia della condizione dolorosa dell'uomo: chi li ha frequentati lo sa bene! [27] Aristotele non era un malinconico, a differenza di Platone, il cui concetto di mania appare come l'esito di una esorcizzazione della sapienza filosofica: non a caso i Neoplatonici del Rinascimento si erano scelti come patrono Saturno. [28] Si ricordi a questo proposito l'importanza e il significato degli spaventi notturni di cui il Leopardi parla spesso. [29] Zibaldone, 103-104; ma si veda anche Zib. 4192, passo del 1824. [30] Si ricordi lo "star seduto" de L'infinito. [31] «La filosofia moderna non fa altro che disingannare e atterrare», afferma Leopardi. [32] Si pensi ai poemi filosofici Peri physeos dei Presocratici. [33] Zibaldone 2710ss. [34] A questo proposito, c'è un'osservazione molto interessante del Leopardi circa il peccato originale: contrariamente all'opinione comune, egli afferma che quello di Adamo e di Eva è il peccato dell'intelligenza, perché essi hanno voluto essere come Dio assumendo per sé lo strumento dell'intelligenza (ma, come dice Bergson, «la vita è più dell'intelligenza»). [35] Cfr. LUPORINI, Leopardi progressivo. [36] Si veda, oltre alle Operette morali, il Discorso sopra lo stato presente dei costumi italiani. [37] Da notare un fatto emblematico: già nel 1855, quando in Italia nessuno ne parlava, un esule russo, sulla rivista Atheneum François, definiva il Leopardi «uno dei più geniali pensatori che ci offra la filosofia». [38] Del primo si veda quel delizioso libretto che è Sul mestiere dello scrittore sullo stile, tr. it. Milano, Adelphi, 1993 [39] Si vedano i rilievi negativi mossi da Shopenhauer sul modo di scrivere di Hegel. [40] «Lo stile è la fisionimia dello spirito» (Shopenhauer, Sul mestiere, cit., pg. 42). [41] Zibaldone 1456. [42] Ciò spiega perché ci siamo soffermati sul vissuto del poeta: è lui stesso che ci invita a farlo, non solo l'amore per la psicanalisi! [43] Come dice la Kristeeva (op. cit.), «la malinconia mi conferisce una lucidità straordinaria». [44] Zibaldone 452 del 22.12.1820. Faccio notare che per Leopardi metafisica corrisponde a filosofia in generale. [45] Cfr. Zibaldone 1619. |
|||