JONA OBERSKI
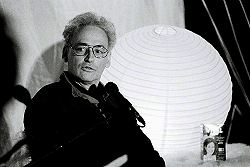
Jona
Oberski è un fisico olandese, nato nel 1938, che ha raccontato, a
distanza di molti anni la sua drammatica esperienza di bambino all'interno
del Lager. I trent'anni che separano la narrazione dai fatti
contribuiscono, forse, a rendere più delicato il racconto che si sviluppa
secondo la particolare, e insolita, prospettiva del bimbo che comprende
solo in parte ciò che gli accade, e vive in modo immediato ed ingenuo
tutto quel che di assolutamente disumano vi è nella vita del campo.
D'altra parte non si può fare a meno di notare come la memoria dei fatti
sia rimasta viva e bruciante nell'uomo adulto che da quell'esperienza è
rimasto segnato. Ne è buona testimonianza il brano seguente, che descrive
la scoperta terribile del corpo abbandonato del padre.
Spunti
per la riflessione
1.
Rifletti sulla singolare prova di iniziazione cui viene sottoposto il
protagonista. Essa indica chiaramente la deformazione mostruosa dei valori
che il lager produce nella mente di quei poveri bambini.
2.
Il lenzuolo assume un particolare valore simbolico. Quale?
3.
Quali sono gli elementi che distinguono questa testimonianza dalle
altre? Da cosa si può notare che la prospettiva è quella di un bambino?
4. Come interpreti le accuse che il bambino rivolge alla madre?
L'osservatorio
Il
giorno seguente mi fu consentito di andare con i ragazzi più grandi,
perché mio padre era morto e io ero stato presente. Ora non ero più un
bambino piccolo. Però dovetti promettere di non fare la spia e di
sostenere una prova. Non sapevano ancora quale. Correvamo sul terreno del
campo. Incontrammo dei bambini più piccoli che mi domandarono se non
volevo restare con loro. Ma io dissi che avevo premura e poi ormai non ero
più un bambino piccolo e se non sapevano che mio padre era morto.
Proseguimmo
la corsa. Due ragazzi più grandi si fermarono accanto a me, uno per
parte. E davanti e dietro ne arrivarono degli altri, anche un paio di
bambine. Io ero certo il più piccolo, ma questo dipendeva dal fatto che
la mia mamma era piuttosto piccola di statura e anche mio padre non era
stato molto alto. Arrivammo all'osservatorio. Uno dei ragazzi più grandi
mi domandò se me la sentivo di entrare. Mi disse che per la verità era
una cosa proibita e anche pericolosa. Domandai perché, ma quello non me
lo seppe dire. Un altro ragazzo disse che avevo promesso di sostenere una
prova e che la prova era appunto questa. Dovevo entrare lì dentro e
restarci fino a quando non mi richiamavano fuori. Dissi che ero disposto a
farlo, ma che non sapevo che cosa c'era dentro, nell'osservatorio.
Domandai se anche loro c'erano già stati una volta, e quelli risposero:
“Si, naturalmente”. Dissi che ci sarei stato se veniva anche qualcun
altro. E se non l'avessi trovata una cosa così paurosa sarei stato anche
disposto a fermarmi e ci sarei rimasto anche da solo, fino a quando loro
mi avessero richiamato. Ma nessuno di loro voleva venire. Io allora
replicai che se lo conoscevano già non avevano alcun bisogno di avere
ancora paura. Un paio di ragazzi bisbigliarono qualcosa fra loro.
Mi
era venuto freddo, perché eravamo fermi lì già da un bel po'. Avevo i
piedi gelati per esser stato nella neve e adesso il freddo mi saliva su
per tutto il corpo. Allargai le braccia e me le battei intorno al corpo
per scaldarmi. E intanto battevo i piedi per terra. Uno dei ragazzi più
grandi mi imitò. Poi disse: “E va bene, vado dentro anch'io con lui”.
Gli
altri bambini si allontanarono un po', il ragazzino abbassò cauto la
maniglia. Era una porta grigia di ferro, molto pesante da aprire. Dentro
era buio. Il ragazzo si strinse il naso con l'indice e il pollice e mi
fece cenno di seguirlo. La soglia aveva un gradino molto alto. Lo
scavalcai. Dentro non si vedeva nulla, era tutto nero; il ragazzino
accostò la porta e si mise a correre davanti a me seguendo la parete con
una mano. Aprì una porta di legno e mi disse di entrare. Aveva una voce
molto buffa, con il naso stretto fra le dita. Non riuscivo a vedere un
gran che. Per terra e ammucchiati contro la parete scura c'erano degli
oggetti bianchi. Anche nel mezzo della stanza ce n'era un mucchio e da
tutte le parti sbucava fuori qualcosa.
Altri
bambini ci avevano seguito. La maggior parte si teneva il naso chiuso. Una
bambina mi disse: “Guarda, là c'è il tuo papà, non ha neppure un
lenzuolo”.
Allora
vidi i morti. Erano fagotti fatti di lenzuola. Da alcuni sporgevano gambe
e braccia. Certi corpi erano nudi. Altri avevano ancora i calzoni.
Giacevano lì, gettati disordinatamente uno sopra l'altro, per verso e per
traverso. Uno stava rovesciato all'indietro in cima al mucchio, la testa
gli penzolava giù. Lo guardai in faccia. Aveva grandi occhi scuri. Le
braccia penzoloni, molto magro. Un altro giaceva con la testa posata su un
braccio teso. L'altro braccio non c'era. Sparsi intorno c'erano anche
pezzi staccati, braccia, gambe. Udii un clic alle mie spalle. Mi voltai e
vidi che i bambini se n'erano andati o si erano nascosti. La porta esterna
era chiusa. Mi volsi di nuovo verso i corpi e cercai di scoprire qual era
mio padre. Piegai la testa in tutte le possibili direzioni, di lato, mi
misi a testa in giù per poter guardare tutti quei volti che stavano
sbiechi o rovesciati. Ma erano tutti terribilmente uguali. E c'era anche
troppa poca luce. Proprio davanti a me c'era, in cima al mucchio, un
fagotto di lenzuola. Dalla forma si vedeva benissimo che c'era dentro un
corpo. Che fosse mio padre? Vicinissimo, davanti a me c'era un corpo sul
pavimento, nudo, voltato a pancia in giù. La testa era voltata di lato.
Che fosse quello mio padre? La testa rasata l'avevano tutti. No, mio padre
non c'era. Doveva essere ancora nella baracca dell'infermeria. E poi lo
avrebbero sepolto. Guardai ancora tutti i corpi attentamente, a uno a uno.
Erano grigi. Le lenzuola sporche spiccavano bianche contro quel grigiore.
Corsi indietro e richiusi dietro di me la porta divisoria di legno.
Arrivai alla porta esterna. Non c'era maniglia per aprire. Cominciai a
battere pugni nella porta, ma non serviva a niente. Udivo i bambini che
stavano fuori.
Tornai
verso l'altra porta, l'aprii di nuovo. Entrai e scavalcai i corpi che mi
stavano davanti. Mi arrampicai sul mucchio e gettai un'occhiata nel
fagotto più in alto. Vidi soltanto un braccio. Cominciai a svolgere il
lenzuolo Fuori udii che gridavano. Tirai fuori il braccio. La mano
somigliava a quella di mio padre Tirai ancora il lenzuolo fino a che
riuscii a vedere la testa. Il volto era nero di barba. Scesi giù dal
mucchio e guardai il corpo di lato. La luce ci arrivava sopra appena.
Cercai di vederlo in volto. Gli occhi erano neri Le guance incavate. La
barba corta come quella del mio papà. Anche il naso somigliava al suo.
Guardai ancora le mani. Assomigliavano molto a quelle del papà. Ma il
corpo non gli somigliava affatto.
Qualcuno
mi afferrò e mi trascinò via, “Sei diventato matto? Vuoi morire? È
molto pericoloso. Vieni fuori. Sono ore che ti chiamiamo, che ti diciamo
di venir fuori”. Risposi che cercavo mio padre e che non ero riuscito a
riaprire la porta. “Tuo padre non è qui” disse il ragazzo. E mi
trascinò con sé, richiuse la porta di colpo e disse che dovevamo correre
via.
Più
avanti incontrammo gli altri. Una delle bambine disse: “Tuo padre non ha
neanche un lenzuolo”. Io dissi che lo aveva sì, il lenzuolo addosso, e
che lo avevo visto con i miei occhi. Lei disse che lo aveva visto anche
lei e che non era vero. Il ragazzo che mi aveva portato fuori con sé
disse che mio padre non era lì, ma quando gli altri gridarono “uh-uh”
e dissero che lui aveva avuto paura, lui rispose che aveva detto così
solo perché io ero ancora piccolo. Ribattei che ero grande e che sapevo
benissimo che mio padre era lì e che lo avevo visto in un lenzuolo e che
potevo mostrarlo a chiunque lo volesse vedere. Ma nessuno volle.
La
bambina replicò: “Ma se tu sai tutto così bene, allora, di', che cosa
ne fanno dei cadaveri?”. Dissi che lo sapevo benissimo, ma che non lo
avrei raccontato, perché avevo fatto quello che dovevo e adesso la prova
era finita. E se lei lo voleva proprio sapere, glielo avrei raccontato,
soltanto però se lei veniva dentro con me. Ma lei non lo voleva e tutti
gli altri bambini si misero a gridarle dietro “uh-uh”. Poi corremmo
via e io ora potevo restare con quelli più grandi.
La
sera la mamma mi domandò che cosa avevo fatto durante il giorno. Le
raccontai che ero stato insieme ai ragazzi più grandi. Mi domandò se mi
prendevano così senz'altro con loro e io le spiegai che ora sì, mi
prendevano con loro, perché avevo superato la prova. Ero stato
all'osservatorio. Lei mi domandò che cos'era, un osservatorio. Risposi
che lo sapeva benissimo, che lì c'erano i cadaveri e che sapeva anche
benissimo che mio padre era stato gettato sopra gli altri cadaveri e che
non aveva neppure un lenzuolo e io avevo detto ai bambini che ne aveva si
uno, mentre avevo visto benissimo che non ne aveva. Mi misi a strillare
che lei era matta a lasciare che lo buttassero così sugli altri cadaveri
senza lenzuolo e che non mi aveva neppure raccontato che era stato portato
via dalla baracca dell'infermeria e che io volevo andare almeno a
salutarlo un'ultima volta e che lei era stata cattiva e che era colpa sua
se era lì così nudo sopra i cadaveri.
La
mamma diceva soltanto: “no”, “non è vero”, ma io non l'ascoltavo
e non la smettevo e le dicevo che non aveva bisogno di mentire con me,
perché tanto avevo visto tutto con i miei occhi. Alla fine scoppiai in un
pianto dirotto, terribile.
[Jona Oberski, Anni d'infanzia. Un bambino nel lager, Firenze, Giuntina, 1989]